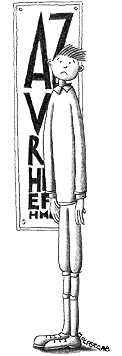
Avevo
sette anni, nel 1963, quando si scoprì che
ero miope. Mio padre mi accompagnò in ospedale
per una visita oculistica. Dopo una breve
anticamera entrammo in una stanza buia dove
mi fecero sedere su uno sgabello; ricordo
due camici che si muovevano e alcuni rettangoli
illuminati.
Il medico mi chiese se vedevo qualcosa: "Certo,
un rettangolo illuminato!". Allora mi
appoggiò sul naso uno strano aggeggio e vi
inserì dei cerchietti di vetro: "Accidenti,
sul quadro ci sono delle lettere!". Mise
altri cerchietti e poi li sostituì, chiedendomi
se vedevo meglio: ovvio che vedevo meglio,
ora riuscivo a vedere grosse lettere nella
parte alta del quadro e linee confuse più
sotto.
Ogni volta che il dottore cambiava quei vetrini
mi chiedeva: "Ora riesci a leggere qui?".
No che non potevo leggere lì: se c'era scritto
qualcosa era troppo piccolo! Ma intanto si
faceva strada in me l'idea che se qualcuno
me lo chiedeva probabilmente avrei dovuto
vedere quello che mi veniva indicato e tutto
ciò mi dava la sensazione di essere in qualche
modo anormale.
Alla fine della visita mi venne diagnosticata
una miopia di tre diottrie. Quando mia madre
lo seppe scoppiò in lacrime e io non capivo
perchè; per me la cosa che contava di più
era aver concluso quell'esame di destrezza
nella lettura che mi aveva visto sconfitto.
Tuttavia la reazione di mia madre era comprensibile.
Aveva già dovuto affrontare quel tipo di problema:
oltre ad essere lei stessa miope, lo erano
anche le mie due nonne; evidentemente era
un vizio di famiglia, o meglio una caratteristica
ereditaria.
Mi fu preparato un paio di occhiali da vista.
Le appendici visive non erano ancora diventate
un accessorio di moda; la scelta delle montature
era molto limitata e i colori disponibili
erano nero o tartaruga scuro: tristi per un
bambino! Ciò nonostante gli occhiali avevano
qualcosa di magico, perchè mettendoli il mondo
si schiariva e anche gli oggetti lontani assumevano
forma e colore. Purtroppo, però, usare le
lenti non era un segno positivo di distinzione
e quando diventai un po' più grandicello la
categoria dei "quattrocchi" godeva
di speciali privilegi: "Non si picchia
uno con gli occhiali!". Nei confronti
delle lenti si veniva così a creare una sorta
di odio-amore: se da una parte mi consentivano
finalmente di vedere bene i giocatori di calcio
allo stadio, dall'altra non mi aiutavano quando
c'erano da fare gli occhi languidi a quella
ragazzina carina del primo banco.
Periodicamente, i miei genitori mi accompagnavano
dall'oculista che mi sottoponeva alla prova
di destrezza: ogni volta era una nuova sconfitta.
Con gli occhiali non riuscivo a leggere i
caratteri più piccoli, il medico dichiarava
un peggioramento e mi prescriveva lenti più
forti.
Nel frattempo si andavano diffondendo le lenti
a contatto. Non sapevo di che cosa si trattasse,
ma l'idea di potermi liberare degli occhiali
era molto allettante. Ancora una volta mi
ritrovai al cospetto di un oculista che mi
mostrava l'odiata tabella ma che, con tutta
probabilità, mi avrebbe prescritto le lenti
a contatto. Il dottor Parducci era un omone
paterno molto paziente e, dopo una visita
accurata, scrisse una ricetta che sentenziava:
"Fine degli occhiali".
Per la prima volta fui contento di essere
stato da un oculista.
Le lentine vennero ordinate al laboratorio.
Erano del tipo rigido della ditta Galileo
e una volta indossate davano la sensazione
che sull'occhio fosse appoggiata una piccola
trave, ma permettavano una visione nitidissima
e per di più... senza occhiali! Inoltre, con
il passare del tempo, la fastidiosa impressione
di corpo estraneo andava scomparendo.
Era il 1971 e avevo quindici anni. Da allora
la mia miopia non è più peggiorata. Il fatto
potrebbe sembrare strano perchè avrei studiato
per molti altri anni ancora e avrei dovuto
superare l'età dell'adolescenza: a detta dei
medici, due fasi estremamente critiche che
forse avrebbero comportato nuovi peggioramenti.
Il destino ha voluto che ne capissi la ragione
più tardi, grazie alla mia attività di optometrista
che sarebbe iniziata dieci anni dopo.